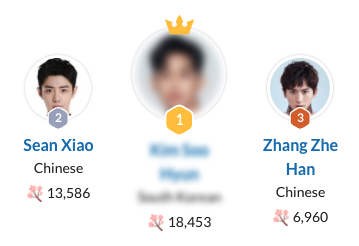This review may contain spoilers
“Kimi wa Petto”: l’amore come comfort zone
Tratto dal manga di Yayoi Ogawa, Kimi wa Petto è diventato un piccolo fenomeno della cultura pop giapponese, con una prima versione televisiva nel 2003 e un remake nel 2017. Dietro la sua veste da commedia romantica moderna, la serie racconta però qualcosa di più inquietante: una forma di amore addomesticato, in cui la relazione serve a proteggersi dalla vita più che a viverla.
Sumire Iwaya, giornalista redazionale in un importante quotidiano della città, che ha focalizzato la propria esistenza nella carriera lavorativa, accoglie in casa un giovane ballerino che le propone di diventare il suo “pet”. Non un partner, non un amante: un animale da compagnia umano, sempre presente e mai problematico. Quello che a molti appare come un gioco ironico sui ruoli di genere, in realtà rivela una profonda paura dell’altro.
Sumire non cerca un incontro, ma una "zona di conforto" in cui sentirsi amata senza mai rischiare davvero. Il rapporto con Momo diventa così un modo per evitare la vulnerabilità e il conflitto: un amore senza attrito, fatto di tenerezza controllata e dipendenza reciproca.
In questo senso, la serie riflette un tratto tipico dei nostri tempi: la tendenza a preferire relazioni che non mettano in crisi, come quelle con gli animali domestici, capaci di dare affetto incondizionato ma incapaci di restituire la fatica dell’alterità. È un sentimento rassicurante, ma anche sterile, perché privo della dimensione adulta dell’amore — quella che nasce dallo scontro, dal limite, dalla scoperta dell’altro come diverso da sé.
"Kimi wa Petto", forse senza volerlo, mostra questa deriva con straordinaria chiarezza. L’amore, per essere umano, dovrebbe contenere il rischio del dolore e dello scontro, la vertigine dell’incontro con l’altro. Quando lo si riduce a un rifugio, a una forma di auto-consolazione, non è più amore: è solo la sua imitazione più docile, e più triste.
Ho guardato i primi 5 episodi, l'ultimo e sinceramente, annoiata/infastidita, ho droppato il tutto.
Sumire Iwaya, giornalista redazionale in un importante quotidiano della città, che ha focalizzato la propria esistenza nella carriera lavorativa, accoglie in casa un giovane ballerino che le propone di diventare il suo “pet”. Non un partner, non un amante: un animale da compagnia umano, sempre presente e mai problematico. Quello che a molti appare come un gioco ironico sui ruoli di genere, in realtà rivela una profonda paura dell’altro.
Sumire non cerca un incontro, ma una "zona di conforto" in cui sentirsi amata senza mai rischiare davvero. Il rapporto con Momo diventa così un modo per evitare la vulnerabilità e il conflitto: un amore senza attrito, fatto di tenerezza controllata e dipendenza reciproca.
In questo senso, la serie riflette un tratto tipico dei nostri tempi: la tendenza a preferire relazioni che non mettano in crisi, come quelle con gli animali domestici, capaci di dare affetto incondizionato ma incapaci di restituire la fatica dell’alterità. È un sentimento rassicurante, ma anche sterile, perché privo della dimensione adulta dell’amore — quella che nasce dallo scontro, dal limite, dalla scoperta dell’altro come diverso da sé.
"Kimi wa Petto", forse senza volerlo, mostra questa deriva con straordinaria chiarezza. L’amore, per essere umano, dovrebbe contenere il rischio del dolore e dello scontro, la vertigine dell’incontro con l’altro. Quando lo si riduce a un rifugio, a una forma di auto-consolazione, non è più amore: è solo la sua imitazione più docile, e più triste.
Ho guardato i primi 5 episodi, l'ultimo e sinceramente, annoiata/infastidita, ho droppato il tutto.
Was this review helpful to you?